
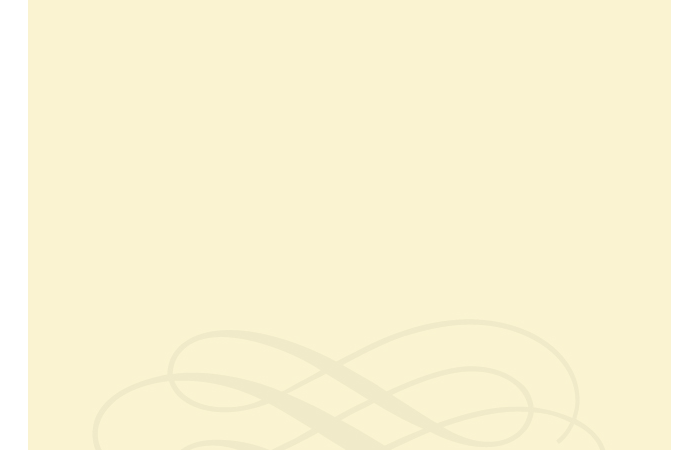
FOTOGRAFARE?
Se c’è un’operazione peregrina e al tempo stesso nociva è quella di voler costringere entro la gabbia delle definizioni il lavoro di un artista. Con William Xerra diviene addirittura impossibile: pittore? Artista concettuale? Virtuoso della tecnica? Collezionista di immagini? Nulla di tutto questo e tutto questo insieme. Una visita alla sua casa studio sui colli piacentini è un’esperienza particolare, tra gli oggetti, le opere le sue e quelle degli altri raccolte nel corso di una vita. Si salgono si scendono scale e finalmente si arriva nella sua tana, collocata su due livelli, dove sono i quadri, le sculture, i giochi, i libri, i cataloghi di una vita di lavoro. Xerra ci ha creduto molto e ancora adesso, nonostante le posizioni di insofferenza dei confronti di un sistema dell’arte sempre più arrogante, ci crede ancora. Abbiamo qui tentato di ripercorrere il suo cammino con un particolare interesse nei confronti dell’utilizzo del linguaggio fotografico.
A.M.: Vogliamo parlare della tua formazione.
W.X.: Ho fatto il liceo artistico e poi l’accademia a Brera, ma non l’ho finita perché non mi trovavo bene con Domenico Cantatore. Sin da ragazzo mi piaceva la pittura e sapevo che le avrei dedicato molto tempo. Certo è stata una bella gioventù, ma prima o poi bisogna crescere, anche se credo di essere rimasto un ragazzo ben oltre i cinquant’anni. Negli anni della formazione, alla fine del Cinquanta, mi piaceva molto Morandi, lo guardavo come il mio maestro ideale. Dipingevo nature morte.
È un amore che dura ancora?
A un certo punto mi sono staccato da lui, durante tutta la sua vita si era rintanato in uno spazio chiuso, senza mai guardare fuori, non si può non scomporsi di fronte alla guerra, al lancio della bomba atomica.
Morandi è stato un pittore, un uomo antico, leggeva i Pensieri di Pascal, che teneva sul comodino.
Certo, capisco, ma poi ho avuto bisogno di cancellare la mia pittura, i miei amori e dunque Morandi per riuscire ad andare avanti. Nel frattempo all’Accademia avevo conosciuto Davide Boriani, Grazia Varisco, Gianni Colombo, i loro discorsi mi affascinavano, ma mi facevano anche una gran paura, paura di trasgredire. In fondo a quell’epoca ero un giovane provinciale, anche se desideroso di sapere.
Cercavo di guardare molto, di capire. Già da allora sentivo la necessità di uscire dal quadro. Poi ho scoperto Ben Shahn, che è stato per me fondamentale e mi ha scosso nel profondo. Inoltre mi piacevano De Koonig, Afro, Tapies, Rothko, le geometrie poetiche e monocromatiche di Nicholson, i sacchi di Burri, il ribelle Fontana. Avvertivo la necessità di riorganizzare lo spazio attraverso il gesto materico, cosmico.
Leggevi anche testi teorici?
Sì, anche se con qualche difficoltà, i testi di Argan, affascinato da Harold Rosenberg sulle cui pagine ho passato molte ore.
Gli anni Sessanta sono stati un periodo di grande rottura, di conquista sociali, politiche. Quanto ha pesato tutto questo su di te?
Parecchio. Il mondo è anche l’Italia, nel suo piccolo, stavano cambiando. Un’esperienza quella di quegli anni che mi ha introdotto nella comunicazione. Mi ha fatto riflettere sulla tragedia della vita, sulla guerra, sulla violenza, il consumismo.
Temi che sono anche oggi di grande attualità.
Tra l’altro in quel periodo lavoravo come grafico alla RDB e iniziavo ad avere confidenza con i letraset. Ho abbandonato quasi totalmente la pittura a olio per arrivare al fumetto, mi servivo dell’acrilico.
Negli anni Sessanta ho conosciuto Antonio Porta, Poi Corrado Costa, Adriano Spatola, Emilio Villa. Con la poesia visiva ho iniziato a capire l’importanza del racconto, mi ha arricchito di nuovi alfabeti: il verbale e il visivo, che rimettono in discussione i rapporti dell’arte e del bello. Attraverso di loro mi sono reso disponibile a questa nuova avventura dell’arte. Sono diventato molto amico di Corrado Costa, che non voleva raggiungere la notorietà, voleva, piuttosto, lasciare dei segni un po’ dappertutto, voleva seminare. Gli devo molto. Mi ha dato l’input della cancellazione, della correzione.
E con Emilio Villa che rapporto hai avuto?
Partivamo dall’Emilia con la Mercedes di Corrado Costa per raggiungerlo a Roma. Era un intellettuale straordinario. Era un pozzo di sapere, per me lui e Costa sono stati una medicina. Poi ho scoperto la poesia concreta e sonora.
E John Cage?
Mi interessava moltissimo la sua ricerca, il pianoforte preparato e quindi il valore del silenzio. Non bisogna dimenticare che il compositore americano è stato profondamente influenzato da Marcel Duchamp e da Erik Satie e che ha frequentato il mondo Fluxus.
In quegli anni partecipi anche agli happening di Fiumalbo, sull’Appennino modenese?
Ho respirato un’aria nuova, arte come vita, gioco, annullamento.
Intanto in tipografia con correzioni di bozze ho scoperto il significato del termine “vive”, l’annullamento di una cancellazione. Il suo ricupero. Una presa di coscienza.
Erano gli anni Settanta…
In quegli anni ho vissuto esperienze importanti. Ho utilizzato la parola, l’azione, la scultura e l’ambiente, la fotografia, il libro-oggetto, il fumetto, la lapide, le performance. È nato il lavoro dedicato a San Damiano e ancor prima il poema flipper con Costa.
Proprio nel 1970 ho conosciuto nella galleria di Luciano Inga Pin a Milano, Pierre Restany, con il quale ho mantenuto un rapporto di scambio e di amicizia fino alla sua morte, avvenuta nel 2004.
Che uomo era?
Non era un critico, ma un uomo di elevatissima cultura, di alto pensiero, che considerava l’arte vita.
Riprendiamo il discorso…
Penso di avere sempre raccontato attraverso opere che promettevano qualcosa di incompleto, nella possibilità permanente di portarle a termine come regno possibile del tatto, dell’olfatto, dello sguardo, dell’udito.
È il dubbio laico della nostra contemporaneità.
Bertold Brecht diceva che tutte le arti contribuiscono a quella più grande di tutte, l’arte del vivere, era la poetica di Fluxus. Rosenberg aveva affermato concetti molto simili.
Che ruolo occupa la fotografia nella tua ricerca?
Sono soprattutto un utente. Mi sono servito di immagini già esistenti o realizzate da altri per il mio lavoro. Come a Matera, in Percorso rituale, dove ho lavorato con Angelo Saponara, una sorta di asceta laico. Ho fatto parlare delicatamente i vuoti. Mi interessava e mi interessa la bellezz della fotografia, volevo fucilarla, graffiarla, tagliarla, fare degli innesti. A matera ho cercato una banda di suonatori di strumenti popolari, in tutto quattro, e con loro abbiamo percorso le strade della città antica, in una sorta di performance. Tracciavo per terra e sui muri dei segni bianchi, e loro passavano per lasciare una traccia. Un bambino, come un chierichetto, portava il secchio della pittura. Ho trovato un frammento di vetro, sul quale ho scritto: «VIVE», l’ho poi lasciato cadere e nuovamente si è frantumato. Un’azione simbolica.
In Verifica del miracolo (1973) la fotografia è documentazione di un’azione. Hai utilizzato la fotografia come un registratore?
L’amico fotografo Prospero Cravedi mi ha ripreso a San Damiano durante l‘attesa apparizione della Madonna. Erano presenti parecchie persone del mondo dell’arte e della cultura, che si erano mischiate con il popolo dei fedeli.
Quando hai utilizzato la fotocamera per la prima volta?
Avevo cominciato già negli anni cinquanta, utilizzavo la Voigtländer a soffietto, di mio padre. Talvolta l’ho percepita come un grande pennello.
Il frammento è una costante della tua opera?
Sin da ragazzo mi hanno sempre colpito, più che le opere complete, i frammenti, ciò che rimane, dopo il passaggio inclemente del tempo. A volte sono più belli dello pera nella loro totalità. Penso che la fase più importante nell’opera di Michelangelo sia proprio in non finito. Negli anni Settanta, in pieno Concettuale il mio utilizzo del frammento acquista una valenza particolare.
Il frammento in pittura e in fotografia hanno lo stesso valore?
Hanno lo stesso valore.
Avverto una forte componente sociale nel tuo lavoro sia del passato che del presente.
Nel mio lavoro c’è sempre un collegamento con la realtà. Da molti anni ho la necessità di prendere distanza dall’opera, per una posizione fortemente autocritica. La mia è una presa di coscienza. nel 2002, con IO MENTO sento la consapevolezza della mia messa a nudo. L’arte ha la capacità di riprodurre, di raccontare, basata sull’esperienza tecnica e conoscitiva. L’evoluzione è prima di tutto nella coscienza degli individui. Se subiamo il fascino della false promesse l’inquinamento culturale, mentale si rafforza. Con questo inquinamento non possiamo illuderci di salvare il mondo.
Nel nostro tempo l’arte ha cambiato molto: le attività artistiche, poetiche sono diventate estremamente contraddittorie, violente. Siamo stati sepolti da un conformismo globale, dal quale dobbiamo liberarci.
Nel 1999 hai dato vita a un’opera particolare la Via crucis.
È una riflessione sul percorso dell’uomo. Un’operazione di senso che mette in luce un presente. Si comunica l’ovvio e il vano in una tempo in cui la tecnologia e l’arroganza fanno spettacolo. La cultura è diventata intrattenimento con effetti speciali e protesi tecnologiche. L’arte deve rendere. Più è svuotata di senso e meglio è. Stiamo vivendo un processo di diseducazione e assistiamo, inermi, allo smarrimento, alla preoccupazione di assistere la dispersione della nostra eredità culturale. la società dell’arte è uno spreco di incredibili storie, di ribellioni velleitarie e mobilistiche fatte di nulla: stiamo vivendo una sorta di manierismo trionfante. E in tal senso non possiamo dimenticare le riflessioni di Giulio Carlo Argan sulla morte dell’arte. Mi piace qui ricordare le parole di Jean Baudrillard: «Il destino dell’arte è in rapporto diretto con l’eutanasia delle forme politiche ideologiche e sessuali della nostra società […] La proliferazione culturale corrisponde al grado zero dell’arte, quello della sua sparizione».
Possiamo chiudere la nostra conversazione con una riflessione ad ampio respiro sulla fotografia, sui nuovi mezzi.
Le tecniche e il processo tecnologico hanno cambiato, a partire dalla metà del XIX secolo, la tavolozza degli artisti. Il fotografo è riuscito a raccontare con maggior rapidità il suo circostante. Man Ray ci ha lasciato ritratti straordinari, immagini emozionanti. Dalla fotografia siamo passati al cinema, alla pellicola, sino alle tecnologia più avanzate del nostro tempo. Se potessi tornare indietro e ricominciare tutto da capo farei il regista. Mi piace citare le parole di Peter Greenaway «Per duemila anni i pittori hanno condizionato la maniera in cui vediamo il mondo. I pittori sono stati i soli che ci hanno addestrato alla visione sino all’avvento della fotografie e del cinema, che ci hanno fornito una conoscenza di mondi che l’occhio non può vedere. […] Dobbiamo inoltre considerare che la maggior parte delle persone sono analfabete da un punto di vista visivo».
A questo punto ripensando alla mia ricerca, forse si potrebbe affermare che la mia è un’operazione antifotografica: la fotografia, infatti, tende a fissare, mentre a me interessa rimuovere.
Angela Madesani
Ziano Piacentino agosto-settembre 2011

