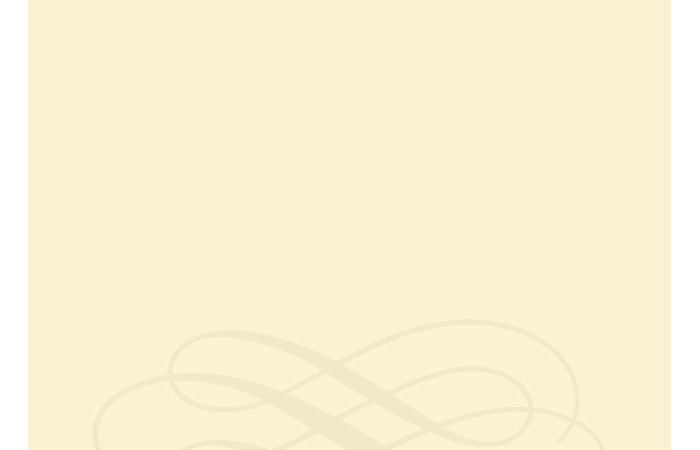Cognizione del dolore e speranza religiosa
[1] A lungo nella cultura e nella religiosità europee si è praticata l’imitatio Christi, il ripercorrerne – attraverso l’esempio del “vero Dio” e “vero uomo” – tutte le tappe dell’esistenza. Portare la croce, soffrire, disperarsi, cadere. Essere trattati ingiustamente, scherniti, umiliati, separati dalle persone più care, guardati con pietà solo dai reietti, aiutati dagli estranei, abbandonati e traditi da coloro in cui riponevamo la nostra fiducia. E, alla fine dell’esistenza, la morte, con il suo terribile carico di angoscia e di mistero. Se Gesù ha sopportato tutto questo, se persino Dio è morto per ciascuno di noi, perché dovrei essere esente dalla sofferenza? Ma, se Cristo è risorto, perché non dovremmo risorgere anche noi? Sollevarsi dopo ogni caduta, vedere la luce dopo le tenebre è un desiderio potentemente manifestato in quasi tutte le culture. L’idea nuova introdotta dal cristianesimo è che ciascuno possa ricominciare da capo la propria esistenza per mezzo del perdono, che spezza la spirale delle vendette e dei risentimenti e distacca dalla vischiosità di un passato che si rifiuta di passare. Se noi perdoniamo o veniamo perdonati, l’offesa che abbiamo fatto o ricevuto e che ci fa soffrire non viene certo cancellata e dimenticata. È il suo peso che cambia, che non ci schiaccia più, che non imprigiona più le nostre energie legandoci a quanto è stato. Il “destino”, ciò che connette alle “colpe” del passato, appare così sconfitto. E quale destino è per tutti più inesorabile della morte, del simultaneo annullamento di noi stessi, delle persone e della cose che ci circondano, del mondo intero?
Nelle strade e nelle piazze di molte città è ancora possibile assistere, durante la Settimana santa, alla solenne messa in scena della passione, della morte e della resurrezione di Gesù. In effetti vi si celebrano – in maniera pubblica e corale – anche le più grandi passioni che agitano e orientano gli uomini: la paura, la speranza e la felicità. La disperazione sentita dai fedeli nel ripercorrere la Via Crucis mima i dolori e le umiliazioni di tutti, cui neppure il figlio di Dio riesce a sottrarsi. Lasciato solo dai suoi discepoli nella veglia dei Getsemani, tradito, deriso, fustigato, viene alla fine ucciso come un delinquente, con lo strumento della morte spettante ai non cittadini e ai ribelli (dopo la sommossa di Spartaco, gli schiavi sconfitti furono crocifissi a migliaia lungo la via Appia). La scelta stessa del simbolo della croce da parte dei cristiani rappresenta una provocazione simile a quella di chi oggi prendesse una forca o una sedia elettrica come emblema del proprio credo.
La Passione mostra come il Cristo si spogli di ogni potere e si presenti nella sua angoscia, esposto al male e volutamente inerme rispetto ad esso. Di questa fragilità dinanzi alla morte è testimonianza suprema la Crocifissione di Mathias Grünewald a Colmar, con il suo Cristo contratto e abbandonato nella spasimo di una consumata agonia. Ma anche la cruda, terribile, testimonianza dello scrittore ebreo Elie Wiesel, quando ne La notte racconta l’impiccagione di prigionieri in un campo di concentramento tedesco: “I due adulti non vivevano più. La lingua pendula, ingrossata, bluastra. Ma la terza corda era immobile: anche se lievemente il bambino viveva ancora… Più di mezz’ora restò così, a lottare tra la vita e la morte, agonizzando sotto i nostri occhi. E noi dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo quando gli passai davanti. La lingua era ancora rossa, gli occhi non ancora spenti. Dietro di me udii il solito domandare: – Dov’è dunque Dio? – E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: – Dov’è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca”.
Bevuto l’amaro fiele della morte, vi è la possibilità di risalire? Dopo ogni caduta, ci si può rimettere, risollevare? Il cristianesimo si fa portatore di questa attesa, proclamando la ‘resurrezione’ di ognuno. Una speranza che ai laici è inibita, ma che lo scrittore svizzero Gottfried Keller ha descritto per analogia, nella sua dimensione umanamente indimostrabile ed esorbitante. Capitato in un obitorio e vedendo morti di tutte le condizioni sociali e di tutte le età, messi uno vicino all’altro, li paragona infatti, con immagine pudicamente carica di desiderio, a emigranti che dormono nel porto con le loro povere cose aspettando il sorgere del giorno. Il laico resiste alle seduzioni di una vita eterna in cui si godrà di una felicità senza fine, sospetta che esse costituisca una illusione compensativa per i realissimi mali del mondo, una promessa fatta per rafforzare l’ordine sociale o lo sforzo incessante per dare senso a una vita che altrimenti apparirebbe assurda. Sbaglierebbe però e cadrebbe nella più piatta banalità se pensasse che la speranza religiosa si riduca a vuota mitologia: l’eliminazione di questa speranza, così come l’eliminazione del desiderio, si paga con l’atrofia, con l’istupidimento, con la mancanza di tensione progettuale.
[2] Oltre la Via Crucis come sacra rappresentazione, mimata nella Settimana santa, vi sono le raffigurazioni nella chiese della quattordici stazioni, simili a quelle che accompagnano l’opera di William Xerra e che, nella versione di un maestro lombardo del primo Settecento, il nostro pittore si è tenuto nello studio per un anno, guardandole e meditando. Sono quelle stesse che ha esposto nella Sala Capitolare di San Giovanni a Parma, e vengono qui presentate in una doppia versione: la prima, formata da quattordici tele inserite ciascuna in una particolare composizione (che ha, a sinistra, l’antico maestro e, a destra, il commento-riflessione di Xerra) e quella più recente, dove i dipinti o le installazioni dell’artista di oggi si emancipano di fatto, ma non idealmente, dal loro modello settecentesco.
Xerra ha meditato su queste immagini, sul loro significato, sulle loro implicazioni, lasciando che sprigionassero lentamente il loro senso, le loro emozioni; che risuonassero e comunicassero; che facessero germogliare in lui altre immagini e altre parole. Lo ha fatto in senso ‘laico’, ma con una procedura antica. La meditatio – da cui anche lo spagnolo medida, “misura” – è originariamente un modo per riflettere sulla pagina del testo sacro, prendendone le misure, ritornando con serena pazienza su ogni passo, leggendo e rileggendo, così da farne scaturire tutti i significati, da far crescere il testo su se stesso, a valanga. Solo che la meditazione di William Xerra non si sviluppa unicamente in pensieri, ma, appunto (come è tipico di un pittore che è stato anche poeta e che ha praticato la poesia visiva: non solo Ut pictura poësis, ma in lui la poësis come pictura), in immagini e parole. Per questo usa sacchi di caffè con scritte, corsivi alla Cy Twombly, collages alla Schwitters, velature ottenute con carte che ricoprono agrumi. Il suo controcanto, nella prima serie della Via Crucis, è formato da acuminate piramidi visive con progressive gradazioni di oscurità, quasi a segnare l’avanzare dell’ingiustizia in forma di dura lex, sed lex [I]; da una specie di tomografia cerebrale, con il cervello diviso da circonvoluzioni appena accennate sulla parte sinistra a rappresentare l’immagine della Veronica in noi [VI]; da una donna nuda alla Picasso a significare il passato della Maddalena e l’attrazione che l’eros esercita su tutti [VIII]. Una citazione di Piergiorgio Bellocchio – da un articolo del 1985, Dalla parte del torto –, relativo all’inciviltà che avanza e di cui nessuno si preoccupa, appare al margine, scritta col sangue, dell’episodio della crocifissione: “Nessuno si era accorto di nulla. Nessuno si riteneva disturbato” [XI]. Oppure, nella X stazione della nuova serie (Gesù spogliato delle vesti e sul vestito si tirano le sorti), al di sopra di alcuni fogli di giornale, si pone l’agenda, sbiadita e non utilizzata, per segnare giocate serali a briscola.
Perché Xerra ha scelto questo modo di comunicare attraverso la Via Crucis? Perché un ‘non credente’, pur pervaso da spirito religioso e dal sentimento del mistero, si appassiona di questo tema, nelle sue dolorose variazioni: ingiustizia, caduta, distacco, morte? Perché ha sentito il bisogno di approfondire la cognizione del dolore, quello suo e quello di tutti, e di praticare la meditatio mortis, quella sua e quella di tutti? Per prima cosa, occorre capire i riferimenti, a partire da quelli più semplici, che erano ovvi nella cultura del passato, ma che oggi sono diventati marginali e oscuri. Elencando, dapprima, quali siano, nella nostra versione ormai canonica, le quattordici stazioni della Via Crucis: servirà a capire meglio l’opera di Xerra.
Stazione I Gesù condannato a morte.
Stazione II Gesù caricato della Croce.
Stazione III Gesù cade la prima volta.
Stazione IV Gesù incontra la madre.
Stazione V Gesù incontra il Cireneo.
Stazione VI La Veronica.
Stazione VII Gesù cade la seconda volta.
Stazione VIII Gesù incontra le pie donne (o la Maddalena).
Stazione IX Gesù cade la terza volta.
Stazione X Gesù spogliato delle vesti.
Stazione XI Gesù inchiodato alla Croce.
Stazione XII Gesù muore in Croce.
Stazione XIIIGesù è deposto dalla Croce.
Stazione XIVGesù è deposto nel sepolcro.
Non sempre la Via Crucis è esistita nell’era cristiana e non sempre è stata come la conosciamo. Essa ha i suoi antecedenti lontani nei pellegrinaggi a Gerusalemme organizzati dai francescani, dove in un primo tempo si percorreva all’inverso il cammino della Passione di Gesù (ossia partendo dal Santo Sepolcro per giungere alla casa di Pilato). Le testimonianze più remote rimandano al 1228, quando viene ricordato il cammino di Cristo verso il Golgotha e al 1294 quando viene descritto l’itinerario dei pellegrini lungo la via di Cristo verso il Golgotha (ne parla il domenicano Ricoldo di Monte Croce nel Liber peregrinationis). L’idea di un percorso commemorativo prende però forma articolata solo nel 1475 con Bartolomeo da Pola, il quale, nelle sue Perdonanze de la Terra Sancta, racconta il suo pellegrinaggio a Gerusalemme (che include un percorso a sette tappe). Nel 1536 appare poi la Devota meditatio de passione Domini, parafrasi in latino del testo di Bartolomeo, composta probabilmente in ambito fiammingo, che opera la trasformazione del diario di viaggio in libro di meditazione devota, dove ogni tappa è accompagnata da particolari orazioni e una particolare attenzione è messa nel cammino tra una stazione e l’altra, come simbolo della fatica di Cristo e di ognuno nel viaggio della vita. Da quest’epoca in poi la pratica della Via Crucis si diffonde in Europa, con maggiore o minor attenzione al cammino oppure alle stazioni e con ordine e scene diverse (alcune cominciano con l’addio di Gesù alla madre, con l’Ultima Cena o con il Getsemani).
Lo schema a noi noto si diffonde alla fine del Cinquecento (affiancandosi a quello di sette stazioni, che diventano poi dodici), ma le “cadute” perdono il loro ruolo, una volta importante e – per quanto siano tre – divengono episodi come gli altri. È solo tra il XVII e il XVIII secolo che si cristallizza l’attuale schema a quattordici stazioni, mediante l’aggiunta, forse ad opera di francescani spagnoli, al modello precedente degli episodi della deposizione dalla croce e della sepoltura. La prima Via Crucis italiana a quattordici stazioni compare in Sardegna (allora dominio spagnolo) nel 1616. Due santi contribuiscono, infine, nel Settecento a radicarne il culto: san Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751) e sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Il primo fece edificare ben 572 Viae Crucis, tra cui, nel 1741, una al Colosseo, in ricordo di tutti i martiri; il secondo, fondatore dei Redentoristi, ne fissò l’obbligo nel suo ordine e scrisse un libro Esercizio della Via Crucis (1761) più volte ristampato e tradotto.
[3] Anche nell’opera del maestro lombardo, che Xerra ha trovato da un rigattiere, ma che – nella sua spontaneità – bene esprime la pietà popolare di un’arte minore, la Via Crucis ha sia il carattere di dramma ricordato, di pellegrinaggio spirituale, di compartecipazione alle sofferenze di Cristo, di consapevolezza dei peccati e delle cadute di ognuno, sia quello della possibilità di rinascere alla vita. Vi è in Xerra un continuo approfondimento di questo mythos fondativo dell’Occidente (il termine che significa etimologicamente “racconto”, sebbene si tratti di un racconto ineffabile, non perché non si possa dire niente, ma perché c’è troppo da dire, perché non si finirebbe mai di dire: il greco mythos è imparentato al latino mutus). Egli così divide, nella prima serie, la sua composizione in due campi contrapposti, quasi a segnare la distanza tra passato e presente, tra memoria e attualità, tra testo originario e risultati della meditazione. Ma, insieme, anche la continuità del tempo, il confluire del passato nel presente e il risalire della memoria dall’attualità a ciò che non è più se non nel ricordo. In questi quattordici quadri un antico pittore e uno nuovo si con-frontano e si con-fondono. Restano in tensione senza risolversi, ma lanciandosi reciproci messaggi e allusioni, che travalicano i secoli e alludono ad alcune costanti della natura umana. Nella prima stazione (Gesù condannato a morte), non si ripete forse il dramma del Giusto condannato ingiustamente, consegnato dai Farisei (prototipo di mentitori) a Pilato, che per ragioni politiche, per non provocare disordine in una provincia romana ribelle, viene mandato incontro a un sinistro plebiscito popolare? E, nella nuova interpretazione, quel “mento” luminoso che campeggia sul cliché, sui simboli specularmente rovesciati dei partiti italiani della ‘prima repubblica’, non è forse, più che un sintomo di qualunquismo o di disaffezione per la politica, una protesta perché la verità è divisa e irriconoscibile, perché si è costretti a venire a compromessi, condannando quell’uomo che, simbolicamente, rappresenta “la verità e la vita”? Da notare che, dalla prima alla seconda serie, cambia il valore di posizione dei lacerti di tela o, più in generale, della citazioni dall’antico. Il frammento era prima aggiunto e riceveva tutta la sua visibilità, corrispondeva a una memoria forte. Attualmente, è strappato, tolto, figura quasi come un buco, una voragine che rischia di propagarsi all’intera superficie del quadro, a svuotarlo dall’interno. Non sempre, però. Un quadro del cremonese Marcantonio Ghislina (1676-1756), trovato anch’esso da un rigattiere e rappresentante l’Apoteosi di san Giuseppe tra angeli con il bastone fiorito retto da due putti alati, praticamente integro. In quest’opera di Xerra la vecchia tela è dominante, non è un lembo di dipinto antico, come in altre opere, dove è un piccolo “fuoco” rispetto alla superficie totale. Gli interventi del nostro artista consistono in alcune annotazioni non prive di tratti ironici, in un’accesa colorazione geometrica in contrasto con le colorazioni della tela, in alcune veline che sottolineano la ferita dell’opera. È come se l’opera attendesse, fin dalle prime pennellate di Ghislina, di subire queste trasformazioni, come se il presente si incastonasse nel passato e lo prolungasse, accondiscendendo al suo intervento.
[4] L’“io mento” costituisce l’emblema dell’ultima riflessione poetica e pittorica di Xerra. Essa è esposta in un manifesto dell’8 maggio 2002, che contiene una luna serie di ‘menzogne’, tra cui “mento sulla verità come inganno”, “mento sulle mie contraddizioni”, “mento sulle scelte”, “mento insieme agli altri”… Sebbene compaia anche in opere precedenti (dipinta trasversalmente su un baule da viaggio, stampigliata su degli spartiti musicali o accostata a “vive” in una tela con I lie o su un Man Ray del 1924 o su un olio, collage, ferro e vernice su tela del 2000), come logo e cifra sostituisce in genere, nell’ultimo periodo, proprio il “vive” precedente, ossia l’espressione usata dai correttori di bozze per segnalare che la parola o la frase già cancellata devono essere lasciate. Vi è dunque una resurrezione del senso, che resta sotterranea nella Via Crucis: come desiderio di riscatto della miseria umana, riconoscimento della sua fragilità, possibilità ultima di districare la verità dal suo impasto di menzogna. La quinta della nuove Stazioni della Via Crucis mostra il Cireneo che “improvvisaMENTE”. Non è stato Xerra definito il Cireneo di Ziano? Una persona pronta ad aiutare il prossimo, ma consapevole della menzogna che contagia anche l’artista, coinvolto dalla falsità della cultura ufficiale e dal bisogno, spesso di adeguarsi ad essa per potersi affermare, di venire a patti con il mercato per riuscire? Si è sempre sul punto di inquinare la propria ispirazione e, proprio per questo, occorre essere consapevoli dei compromessi praticati e della menzogna che ne consegue, oltre che dell’aridità di un’arte contemporanea, che – dispersa tra mille linguaggi – sembra diventata una Babele priva di ispirazione e di coraggio, malata di alessandrinismo e di epigonalità.
Del resto, l’arte ha sempre avuto uno statuto ambiguo, ha sempre presentato una palese indecidibilità tra verità e menzogna. La letteratura contemporanea ne è pienamente consapevole. Ad esempio, in una della Cosmicomiche di Calvino, Un segno nello spazio, quando Qfwfq traccia il primo segno mai eseguito, quasi la sua firma, questo viene subito falsificato da un altro personaggio, Kgwgk. Ogni cancellazione è un’autenticazione e ha bisogno di un “vive” per riprendersi non la sua presunta originaria autenticità, ma le sue mentite spoglie che forse sono vere. Sempre Calvino sostiene nei Saggi 1945-1985 che lo scrittore il quale mistifica gli altri apertamente con “giochi di destrezza”, è “quello che mistifica meno”, perché mette in luce la convenzionalità dei procedimenti letterari. Allo stesso modo, Antonio Tabucchi ha potuto osservare in Requiem che “la verità suprema è fingere”. Con intenzioni analoghe, il grande poeta americano Wallace Stevens aveva scritto nel 1942 le Notes Toward a Supreme Fiction. Eppure, le finzioni dell’arte molto ci dicono della realtà, perché ci riconducono ad essa più ricchi di senso e, Xerra, attraverso il “mento” cerca in effetti la verità, che si manifesta nel modo più umile anche grazie ai sensi (al Centro San Fedele, ha parlato della “verità dei sensi”, del rapporto con il mondo reso possibile e vivificato dai nostri organi percettivi: dal tatto, ad esempio, oltre che dalla vista).
Tra verità e finzione non c’è, peraltro, in arte né opposizione diametrale, né identificazione. Siamo su un altro piano. Eraclito affermava che tutti gli svegli partecipano a un mondo comune, mentre i dormienti vivono ciascuno in un universo privato. L’arte però rappresenta uno dei diversi e paradossali mondi intermedi in cui la dimensione pubblica e privata, la “realtà” e l’“immaginazione”, il linguaggio si scambiano continuamente i ruoli. I mondi prodotti dall’arte non costituiscono pertanto né un semplice rispecchiamento della “realtà”, né il frutto di una immaginazione arbitraria (nel senso in cui il Cardinal d’Este chiese all’Ariosto: «Messer Ludovico, da dove avete tratto tutte queste corbellerie?»). Mentono e dicono la verità, cancellano la percezione e la comprensione logica del reale per resuscitarla trasfigurata, con i loro mezzi, mediante un enigmatico “vive”. Si potrebbe applicare a Xerra il motto che De Chirico apponeva ai suoi quadri attorno al 1908: “Et quid amabo nisi quod aenigma est?”.
L’arte in genere e la pittura in particolare appaiono quindi quale un “terzo regno”, intermedio tra il presunto “reale” rispecchiato, nella sua unicità, dalla conoscenza (intesa come riproduzione logico-percettiva di esso) e gli altrettanto improbabili prodotti per partenogenesi di una fantasia creatrice ex nihilo. Due concetti specularmente opposti e complementari vengono pertanto messi in mora o distrutti nella loro assolutezza: l’idea di una realtà di per sé vera e indipendente dal linguaggio che la enuncia (una ‘iper-realtà’ che l’arte in genere dovrebbe mimeticamente rispecchiare) e quella di un’immaginazione arbitraria, brada, che – a partire da appigli offerti dall’esperienza – si inventa un mondo che non ha più alcun rapporto con quello in cui effettivamente si vive.
Ciò può aiutarci a spiegare perché l’arte si mostri secondo tradizioni plurimillenarie in maniera talmente contraddittoria. Da un lato, essa appare infatti come potenziamento del senso della realtà, materializzazione in parole, suoni, colori di un mondo più vero di quello offerto dall’esistente da cui attinge la materia, dall’altro c’è un’attenuazione del senso della realtà, considerata appunto nella sua verità a partire dalla sfera logico-percettiva. Sin dagli albori della riflessione occidentale, entrambe le soluzioni mostrano una eguale plausibilità e forza di penetrazione. Contrastano, certo, ma contengono anche un elemento comune, condividono un territorio specifico: che l’arte in genere appartenga simultaneamente ed enigmaticamente alla realtà e alla possibilità, a ciò che è e a ciò che potrebbe essere secondo determinate regole di produzione. Un modo per uscire da questo dilemma e chiarirlo potrebbe essere quella di intendere il territorio artistico come atopia, luogo inclassificabile, che non appartiene né al dominio della realtà assoluta, né a quello – che ne è l’opposto speculare – dell’utopia, del non-esistente per definizione. Giungeremo al luogo in cui il nostro desiderio o le nostre angosce o pensieri più riposti trovano, provvisoriamente, un maggiore appagamento. Forse che questo è la lontananza prossima alla “patria sconosciuta” di cui parlano Plotino e Novalis, all’arrière-pays intravisto da Yves Bonnefoy, a quella zona atopica in cui non siamo mai stati ma che ci sembra di conoscere da sempre, quasi fosse un interno paese straniero perduto e ogni tanto riconquistato? Ciò che non si è mai vissuto e a cui tuttavia si aspira è l’interno paese straniero rappresentato dal mondo del desiderio nella sua inappagabilità, e dalle questioni più insolubili della vita, da quanto ci sta più a cuore e ci tormenta, dalla nostra Via Crucis che speriamo si concluda con la nostra vita. È questa, probabilmente, la ragione per cui l’arte in genere deve continuamente trovare la sezione aurea, l’equilibrio tra la superficialità desensibilizzante delle opere che attingono i livelli profondi dei conflitti e l’eccesso sregolato di coinvolgimento psichico che non sa mantenere le distanze e che conduce allo sprofondare in un abisso informe (come accade nel caso dell’emozione che si prova dinanzi al Cristo morto del Mantegna, che Xerra ha magistralmente riprodotto [guarda i due quadri a confronto], alla Pietà di Michelangelo al Don Carlos di Verdi)
[5] Scelgo alcune tematiche rilevanti in queste opere di Xerra. La seconda stazione della Via Crucis della prima serie propone il tema del rapporto con il passato e la memoria, di un passato non esaurito, che il tempo sembra aver cancellato, ma che silenziosamente continua a vivere (oppure, in questo stesso momento, mente?). Accanto alla tela raffigurante il Gesù caricato della Croce, si stagliano incollati e barrati da una croce nera vecchi documenti burocratici relativi all’azienda agricola di famiglia (quote latte, avvocati), ricordi di croci terrene difficili, ardue da portare. Vi è in Xerra una sorta di vena religiosa, nel cogliere la malinconia del passato, della vita che si distrugge. È un tema quello della memoria familiare e del rapporto tra generazioni che ritorna anche nella vecchia e nella nuova versione della quarta stazione (Gesù incontra la Madre), con significative differenze compositive, ma con simili intendimenti. Nella prima serie il disegno a colori squillanti della nipotina Vittoria si affianca allo sbiadito foglio del congedo militare del padre dell’artista di ritorno dal Montenegro, un incontro e un ricongiungimento sotto la croce della guerra, con il frutto di una continuità e di rinascita nel tempo, che è la bambina e chi le succederà nella catena della vita. Nella memoria riecheggiano le parole: «Ti ricordi William la volta che il babbo è tornato dal Montenegro». Anche nella dodicesima stazione della prima serie compaiono, accanto a foto polaroid scurissime, altri disegni infantili.
Nella seconda serie l’incontro di Gesù con la madre è rievocato mediante un ricordo d’infanzia, di quando William bambino giocava col trenino e con la croce (composta da due matite incrociate) in una montagnola di sabbia dentro una grande tinozza di rame, che serviva alla madre per lavare i panni con la cenere. Il destino del bambin Gesù con la gioia del gioco nel periodo radioso dell’infanzia, aperto a tutte le speranze e a tutti i doni – i tre vagoni rappresentano oro, incenso e mirra – prelude, con triste contrasto, alla fine del cammino, al Golgotha. Richiama il destino di ognuno di noi e la responsabilità dei genitori che ci mettono al mondo per votarci alla morte. O di noi come genitori che mettiamo al mondo i nostri figli con la stessa triste prospettiva. Perché hanno dato a ciascuno questa tremenda responsabilità? Perché Maria, perché nostra madre non ci ha fermato? Perché nessuno riesce a trattenerci nell’infanzia e nell’innocenza, nell’ignoranza del male che ci attende? Perché avanziamo in un mondo in cui siamo fatalmente condotti a perdere progressivamente tutto?
La sabbia è per Xerra anche il simbolo dell’arte, che sfugge dal pugno e che bisogna impastare con l’acqua, per consolidarla, almeno provvisoriamente. L’arte sfugge infatti come sabbia dalle mani. E così il tempo, che è ciò che muore continuamente, eppure continuamente rinasce, finché siamo vivi. Ogni istante ci sospinge dal noto verso il mistero dell’avvenire, ci proietta irreversibilmente in direzione della morte. Ci apre la porta dell’ignoto, come nel Cenotafio veneziano di Canova a Santa Maria Gloriosa dei Frari, dove in una bianca piramide marmorea si schiude, come una ferita da cui escono emorragicamente fiotti di senso, un uscio nero verso cui si dirigono statue allegoriche.
Nella dodicesima stazione (Gesù muore in Croce), la prima serie riporta attorno al doppio quadro un frammento del Vangelo apocrifo di Tommaso: “In modo che due siano uno, che l’interno sia come l’esterno e l’esterno come l’interno. L’alto come il basso e del maschio e della femmina una cosa sola e un occhio al posto di un occhio e una mano al posto di una mano e un piede al posto di un piede, un’immagine al posto di un’immagine”. In questo spartito visivo, una doppia croce di Sant’Andrea, con un tratto di congiunzione tra i due centri delle X, genera due A (simbolo di Assoluto) specularmente rovesciate. Una ulteriore interpretazione della XII stazione mostra un frammento di quadro antico, in forma di striscia sottile, che mostra un Gesù morto, incollato su un pezzo di giornale che porta una scritta che inizia “Noi, indifesi di fronte…”. Nella versione ultima – intitolata One way, “Senso unico” – su un tappeto (di dimensioni 4 x 4) di giornali italiani e stranieri successivi all’11 settembre del 2001, steso per terra per essere calpestato, al centro si situa uno specchio sovrastato da un Cristo capovolto in carta gessata del Seicento. Lo specchio è una citazione della fase in cui Xerra costruiva o riutilizzava lastre tombali in cui lo specchio stava al posto del ritratto del defunto. Il senso era ed è che de te fabula narratur, di te parla la crocifissione di Cristo. Sei tu che attraverso lui che – camminando sui dolori del mondo – ti trovi in cima al tuo Golgotha. Ma un pezzo di ruvido sacco di caffè porta la scritta originale Yo construyo MI FUTURO. È una promessa? È una menzogna? Nel calpestare i fatti del mondo, nel portare la nostra croce ci illudiamo di costruirci un futuro glorioso nell’aldilà?
È lungo l’itinerario attraversato da William Xerra. Per restare solo agli ultimi decenni, è partito dai flipper e dai video degli anni Settanta, per passare alle lapidi dismesse e alle installazioni e ritornare infine alla pittura, con un’arte tecnicamente così raffinata, così densa di memoria e di nuovo, così toccante e, nello stesso tempo, disincantata da saper toccare le corde più profonde dell’esperienza umana. Molte opere e diverse mostre testimoniano l’evoluzione del nostro pittore-poeta. Ma egli è consapevole che il percorso continua, anche se non sa ancora in quale direzione, perché è importante esplorare, perché, come dice un poeta spagnolo, no hay camino, hay que caminar. Buon viaggio, William!
Remo Bodei, 2004